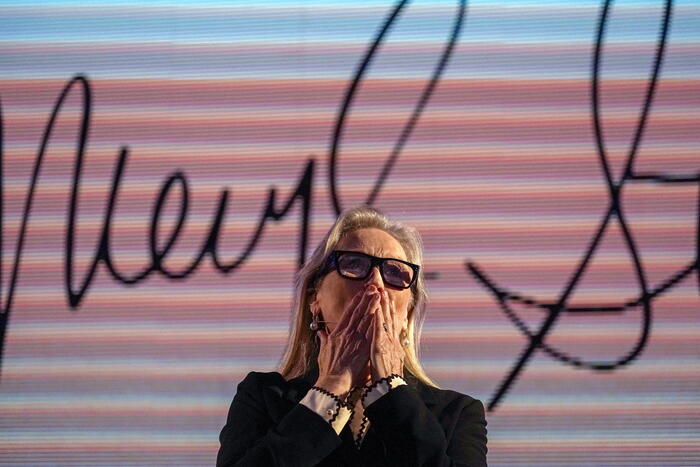venerdì, 3 Maggio 2024
Cowboy Bebop, la serie TV live action di Netflix: la recensione senza spoiler

In questo periodo super-denso di uscite che attendevo da un pezzo, la trasposizione dal vivo di Cowboy Bebop (in arrivo su Netflix tra qualche giorno, il 19) era probabilmente tra le prime cose in cima alla lista. Non fosse altro, per la curiosità (e a ruota il timore, certo) di veder muoversi in carne e ossa dei personaggi a cui sono molto legato. I protagonisti di una delle serie anime più amate, e a buon ragione, di fine anni Novanta, ora in uno show Netflix da dieci episodi, con l’ex Sulu, John Cho, a portare la cravatta, il colletto alzato e i capelli gonfi di Spike Spiegel. La domanda, ovviamente, di tutti gli appassionati è quanto vicina questa nuova versione live-action sia arrivata all’anime originale di Shinichirō Watanabe. E la risposta, lo diciamo subito, è “non abbastanza”. Anche perché era molto difficile (pressoché impossibile) farlo. Non sono più i tempi dell’Anime Night su MTV, e tutto il resto viene di conseguenza.
IL BLUES DELL’ASTEROIDE
La serie anime di Cowboy Bebop era l’imbottigliamento di un fulmine, un qualcosa davvero molto difficile da ripetere. Un anime che doveva nascere per far vendere i modellini delle astronavi a Bandai, ma poi aveva imboccato tutta un’altra direzione, tanto che alla fine Watanabe era stato lasciato libero di farne quello che gli pareva. Ne era uscito fuori, così, un mix assolutamente unico di sci-fi, western e noir (e tanto altro), di ironia e nostalgia, di malinconia da viaggi nello spazio e di ambientazioni che erano un frullato di New York e Hong Kong, ma con i telefoni pubblici e tutto il resto pescato dal Giappone di quel tempo. Visivamente splendido, con una colonna sonora pazzesca di Yoko Kanno (talmente presente e caratterizzante da essere in pratica un altro personaggio) e dei personaggi unici. Sì, con tutto che ai tempi, davanti a MTV, a cavallo tra il 1999 e l’inizio del nuovo millennio, avrei voluto che Ed chiudesse la bocca per almeno cinque minuti.
Ho riguardato tutta la serie qualche settimana fa, per la – boh? – terza o quarta volta. E non ha perso un briciolo del suo fascino. Anzi. Ti godi quegli sfondi, che l’animazione nipponica televisiva non si permette più da un pezzo, su cui si muovono questi personaggi rassegnati, questi volti diversi della solitudine cosmica (e Schopenhauer muto), in una space opera per cui quel jazz-blues in sottofondo è semplicemente perfetto. E arrivi alla fine col magone, oggi doppio, perché sai che qualcosa del genere è difficilmente ripetibile. La storia del fulmine e della bottiglia, appunto.
E qui, in questo coraggioso – va detto – tentativo di trasformare il tutto in una serie live-action da far fruire all’intero pianeta, anche a chi l’anime non l’ha mai visto, la produzione – con il coinvolgimento della stessa Sunrise che aveva prodotto l’anime – la bottiglia l’ha pure portata. Solo che quel giorno non c’era manco mezza nuvola in cielo, e di sicuro zero fulmini.
JUPITER JAZZ
Si parte e – più o meno – si arriva allo stesso punto rispetto all’anime. Da un primo episodio che ricalca quanto più possibile la prima puntata di quest’ultimo (Asimov, la compagna incinta di quelle fiale di Red Eye, e tutto il resto), alla resa dei conti finale con il passato di Spike, cioè il Red Dragon. Ma se all’inizio tutto sembra identico, con solo qualche elemento spostato – Faye arriva subito – man mano che la serie prosegue la distanza rispetto al materiale originale aumenta. Il che, intendiamoci, non sarebbe di per sé un male, perché gli adattamenti 1:1 in genere producono goffe mostruosità. Lo stesso showrunner, André Nemec, ha dichiarato che se fosse stato un fan, gli sarebbe piaciuto vedere qualcosa di leggermente diverso. E ok. Non fosse che qui le scelte adottate per chiudere questa prima stagione sono un po’ discutibili. Soprattutto per quanto riguarda il triangolo tra Spike, Julia e Vicious, perché c’era da lasciare aperto un portone per il futuro.
Tanti episodi, pur con titoli diversi (sempre giocati sulla musica), riprendono delle trame viste nella versione animata, dall’arrivo di Ein ai peluche esplosivi e agli ecoterroristi (che nell’anime erano una palese presa per i fondelli di Greenpeace), ma il tono e giocoforza la resa visiva sono molto diversi. E per quanto diverse siano le premesse rispetto a tante altre serie sci-fi, alla fine la particolarità dell’anime si perde. Mettiamoci anche che i cambi di ambientazione erano facilmente più digeribili nell’originale, mentre qui un intero episodio con Jet Black in versione noir, con tanto di cappello da investigatore, fa sorridere per le ragioni sbagliate.
Tanto, in questo, fa anche la lunghezza degli episodi. La struttura è la stessa, con un traccia di trama orizzontale e tutto il resto verticalissimo, e questo genera per forza di cose una qualità altalenante: alcune storie piacciono di più, magari altre meno. Ma nell’anime anche quello meno brillanti scivolavano via in fretta, mentre qui ogni episodio dura cinquanta minuti. E se t’incagli su quello che non gira, gli occhi ti rimbalzano per quasi un’ora tra l’orologio e il soffitto.
HONKY TONK WOMEN
Ma tutto questo, alla fine, poco conta. Perché importa quello che di Cowboy Bebop, vent’anni fa, ci è rimasto nel cuore. Sì, oltre alla musica. E sono i suoi personaggi. Si è tanto discusso, alla vigilia, della Faye Valentine interpretata da Daniella Pineda, perché in questa serie non è la bomba sexy, vestita pochissimo e dalle forme impossibili, della sua controparte animata. Ma Faye non era solo un personaggio ipersessualizzato da anime anni 90, ma una donna apparentemente sicura di sé e in realtà fragilissima, per via dei luuuunghi casini legati al suo passato. Tutto questo prova ad emergere nella nuova Faye – che in italiano ha la stessa doppiatrice di vent’anni fa, Barbara de Bortoli – e c’è una scena anche abbastanza riuscita che riguarda la scoperta di quello che le è accaduto, ma le manca qualcosa. E no, non si sta parlando di quello, smettetela. È che nel saltare dalle gag ai momenti tristi, è venuto meno quel senso di solitudine e malinconia di cui sopra. Quel mood a metà tra la rassegnazione dei personaggi di Philip K. Dick e i dialoghi alla Elmore Leonard, che rendeva Faye Valentine, Spike, Jet Black (Mustafa Shakir) e tutti gli altri quello che erano. Che rendeva Cowboy Bebop, beh, Cowboy Bebop.
E senza, nulla sembra girare come dovrebbe. Non mi importa che Spike qui è vistosamente più maturo (scelta spiegata da Nemec con l’esigenza di rendere più credibile il suo passato doloroso), mi importa che sostanzialmente non è lui, ma uno vestito come lui.
SUPERNOVA SYMPHONY
Ci sono anche qui le musiche di Kanno, c’è stata la consulenza dello stesso Watanabe e non mancano le occasionali esplosioni di violenza, che, ricordiamolo, crearono grossi casini all’anime in Giappone ai tempi della prima messa in onda. Ma non c’è il Cowboy Bebop che amavo. Una scritta a video, alla fine dell’ultimo episodio, gioca con il classico “See you space cowboy” che chiudeva le puntate dell’anime. Si promette una seconda stagione, che André Nemec ha dichiarato di aver già pianificato.
Ma non so quanta voglia avrò di vederla. Probabilmente poca. See you… ma facciamo che ti chiamo io.
A chi o cosa serve, allora, questa serie? Sinceramente non so dire quanto potrà piacere a chi è a digiuno dell’anime. Magari, senza questo inevitabile paragone fisso in testa, risulterà più fresca e godibile. O magari, senza quello stimolo a confrontare il prima e il dopo, il gioco del com’era e com’è, alcuni episodi più farraginosi verranno a noia prima. Non so. Quel che so è che la cosa buona e giusta è che questo show spingerà probabilmente tanti a scoprire l’anime Sunrise. Quale meraviglia sia stata e resti, quale fulmine poderoso abbia infilato in una bottiglia.
Anzi, in una lattina di Pippu.